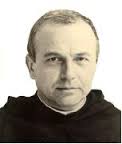
Il TERZO PERIODO DI
RESPOSABILITA’
MONTE BERICO (1922-1925)
Nell’estate del 1922 è ricostituita la Provincia Veneta dei Servi di Maria, e P. Gioachino viene riconfermato nel suo doppio incarico di priore della comunità religiosa di Monte Berico e socio del priore provinciale. Egli è designato anche come segretario delle Missioni della nuova Provincia, e si prodiga in un’intensa attività di formazione missionaria. Il suo animo, però, attraversa difficoltà, a causa dell’insorgere d’incomprensioni con le autorità ecclesiastiche diocesane. Emanuela Zampieri scrive:
“P. Gioachino aveva parlato già a troppe anime, e sappiamo con certezza che la riservatezza richiesta non è stata mantenuta da tutte. Fu riportata in modo errato la fisionomia della Famiglia, la sua spiritualità nuova e non capita a quel tempo. Da questo vennero sospetti, dicerie, giudizi, critiche, ed anche calunnie da persone male informate” (Memorie della Famiglia, maggio 1922).
Ma per P. Gioachino il clima d’incipiente incomprensione diviene occasione per sottolineare alle “figliuole” cosa significhi offrire tutta la vita per congiungersi con il profondo mistero della Passione di Cristo. Scrive infatti:
“Tutto vale per le anime consacrate a Cristo, e con Cristo al Padre Celeste. Candore di Eucaristia, ardore di ostia, abbandono di vittima, silenzio, umiltà, nascondimento, zelo, discrezione, sacrificio: tutto è per noi” (27.7.1922).
Allo stesso tempo, si fa urgente il bisogno di presentare lo spirito della Famiglia per renderla più comprensibile. Per questo egli prende la decisione di pubblicare un foglietto mensile “per alimentare tutte le anime ed aiutarle nella diffusione della devozione al Padre Celeste”. (Memorie della Famiglia, 1922). Nasce così il foglietto che porta il nome di “PATER!…”, eco dell’intensa spiritualità del suo animo: il primo numero esce con la data simbolica del 25 dicembre 1922, come ricordo dell’inizio della Famiglia nel Natale 1919. La pubblicazione incontra subito lusinghiere prospettive di diffusione in varie diocesi del Veneto. Ormai P. Rossetto può scrivere esplicitamente e con ampio spazio riguardo la paternità divina, lo spirito di figliolanza e le sue caratteristiche.
Oltre a questo, all’inizio del 1923 egli presenta al vescovo di Vicenza, che gliel’aveva richiesta, una lunga e dettagliata relazione sull’origine, le opere e soprattutto lo spirito ed il significato della nuova “Famiglia”:
“Si chiamano ‘Figlie di Dio’ perché:
- a) il nome stesso renda più viva la fede in Dio, Padre onnipotente, a Lui si affidino filialmente, e siano felici di poter compiere sempre la sua Volontà di Padre;
- b) si sforzino di amarLo con lo stesso amore che ha dato loro il Figlio suo Gesù;
- c) sappiano rivestire con questa fede e con questo amore tutte le opere della loro vita. …
Esse vivono nel mondo, nelle varie circostanze in cui si trovano ed in cui riconoscono ed amano la Volontà del Padre buono onnipotente. … Il loro abito è la santa modestia, il loro convento il mondo intero, la loro clausura la legge tenerissima di custodire limpido il loro cuore” (4.1.1923).
Il vescovo chiede maggiori dettagli sulla struttura canonica dell’Istituzione, e P. Gioachino si trova in difficoltà a dare una risposta soddisfacente; intuisce che, con l’insistente richiesta di norme precise, non viene compresa la novità della sua intuizione evangelica e missionaria.
La difficoltà sostanziale consiste nel fatto che è ancora ritenuta impossibile una consacrazione che non comporti, per se stessa, la vita religiosa, e quindi l’abbandono della vita e della condizione laicale.
Infatti, il Codice di Diritto Canonico del 1917 sancisce l’esistenza di tre sole categorie di persone: chierici, religiosi e laici, così che la professione dei Consigli Evangelici rende simili ai religiosi e totalmente distinti dai laici.
D’altra parte, la vita comune di alcune Figlie di Dio a “Casa preghiera e lavoro” non contribuisce certo ad appianare le difficoltà. Ma P. Gioachino è convinto che senza un gruppo di vita comune come sostegno non sia possibile una vita consacrata nel mondo.
Comincia, quindi, a far distinzione tra “interne” ed “esterne”, cioè tra viventi nelle Case, a piena disponibilità dell’Istituzione, e viventi in pieno mondo, nelle loro famiglie ed occupazioni.
In una meditazione alle ‘figliuole’, verso la fine del 1923, parlando della margherita, egli conia quello che diviene il simbolo delle Figlie di Dio:
“La margherita è un fiore campestre, coltivato da Dio, esposto a tutte le intemperie, che cresce tanto sui prati come lungo i fossati e sul ciglio della strada. È un fiore formato da un bottoncino centrale, che è l’unione di innumerevoli fiorellini, e da una corona di petali bianchi, anch’essi completi. La margherita è un unico fiore, formato da tanti fiori. Ed è un fiore che guarda sempre il cielo. Ecco il simbolo della Famiglia nostra: un centro, e tutt’intorno altri fiori, petali dello stesso fiore, vivo per la gloria del Padre che lo ha nutrito e fatto crescere. Interne per le esterne. Lo scopo nostro è di far vivere la vita cristiana come al tempo delle persecuzioni” (14.10.1923).
È un cammino di ricerca, che accompagnerà P. Rossetto fino alle soglie del 1930, senza arrivare mai ad una soluzione soddisfacente per le autorità ecclesiastiche.
Siamo nel pieno dell’operosa maturità di P. Rossetto, occupato nella cura della comunità religiosa locale e provinciale, nel ministero del santuario di Monte Berico, nell’itineranza di animazione missionaria e nell’accompagnamento alla “Famiglia delle Figlie di Dio”.
All’inizio del 1924, un ulteriore colloquio con il vescovo di Vicenza non dà risultati incoraggianti. Per di più, le difficoltà cominciano a delinearsi anche fuori Vicenza: il diffondersi della presenza delle Figlie di Dio è osteggiato da alcuni parroci, che vedono con diffidenza un’Istituzione non ancora riconosciuta dalla Chiesa. Sono scogli che acuiscono in P. Gioachino una sempre più lucida coscienza, segnata da un’intensa tensione interiore. Scrive ad una ‘figlia’:
“Ti voglio figlia di Dio missionaria. Non missionaria nel senso comune della parola, ma portatrice del Messia in te stessa. Il Messia non è uscito dalla sua terra per predicare. La Madonna è andata in Egitto, ma non ha predicato: eppure, è la Regina delle Missioni. Predicare con l’esempio, vivere di fede, far respirare la fede attorno a sé, diffondere con umile e costante eroismo la fede: ecco la ragion d’essere delle Figlie di Dio” (gennaio 1924).
Il suo lavoro non si ferma. É attivamente coinvolto nell’apertura missionaria della Provincia Veneta dell’Ordine, e lancia un foglietto intitolato “La Missione della Madonna”. L’impegno di animazione missionaria lo porta anche a Vittorio Veneto. Ne conosce il vescovo fin dalla sua permanenza a Follina, viene da lui bene accolto, viene incaricato del Consiglio Missionario Diocesano con la qualifica di “propagandista ufficiale diocesano”, ed anche là inizia la pubblicazione di un “Foglio Missionario” per tutte le parrocchie.
Continua l’impegno di diffondere la “devozione al Padre”, che si allarga sempre più. Anche alcuni sacerdoti, che ne sono venuti a conoscenza, desiderano farla propria ed approfondirla. Particolarmente due, Don Beniamino Socche, della diocesi di Vicenza, e Don Egidio Piran, della diocesi di Treviso, cominciano con P. Gioachino una corrispondenza epistolare, che si protrarrà per parecchi anni.
Il 15 agosto 1924, anche a Venezia, in accordo con il Patriarca Card. La Fontaine, inizia le sue attività la “Casa Pater”, e P. Gioachino scrive:
“Nella festa del trionfo della Figlia di Dio, nel giorno che ci ricorda la gioia del Padre nell’incoronare la sua Figliola e farla partecipe della sua gloria, un’altra porta si è aperta alle Figlie di Dio. Su di essa hanno scritto ‘Pater’. È un altro nido, da dove le Figliolette si sforzeranno di dare gioia al Padre onnipotente. Là dentro c’è un tabernacolo, lo sguardo di Dio: basta!” (settembre 1924).
Nel 1925 si celebra in tutta la Chiesa l’Anno Santo, indetto dal Papa Pio XI. Per P. Gioachino è l’ultimo anno di priorato a Monte Berico, un anno colmo di fremiti nuovi. In esso si intrecciano due filoni: una vigorosa animazione missionaria ed una strenua fedeltà allo spirito originario che l’ha portato a dar inizio alla Famiglia delle Figlie di Dio.
Egli affronta ostacoli ed incomprensioni senza tentennamenti, nella profonda convinzione che la Famiglia non è frutto suo ma disegno del Padre, nella consapevolezza che la vita delle “Figlie di Dio” non è tanto uno stato, quanto piuttosto uno stile di vita, un cammino intessuto nel “silenzio e nel lavoro nascosto”, un itinerario che, sebbene costellato di “contraddizioni ed umiliazioni”, trova sostegno nella “Provvidenza delicatissima di Dio”, e sfocia in un dinamico apostolato, ancorato sempre più “all’amore del Padre, alla Passione di Gesù, alla grazia dello Spirito Santo” (27.5.1925).
Sorry, the comment form is closed at this time.