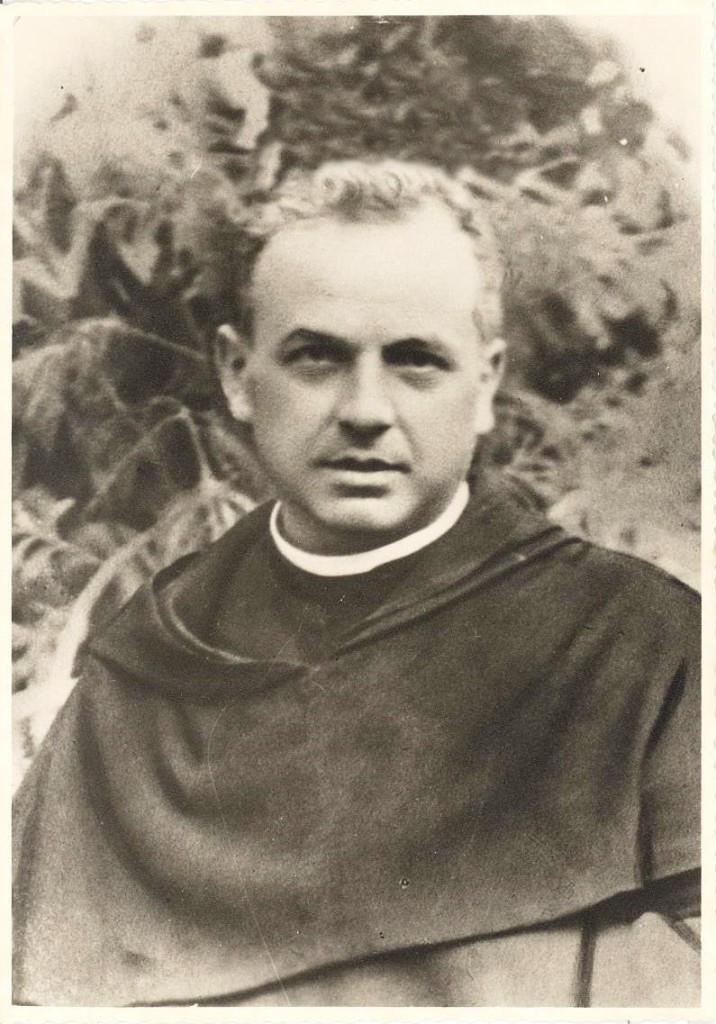
ESPERIENZA
MISSIONARIA
(1912-1914
P. Gioachino va a Roma in un clima di incertezza, poiché le trattative ufficiali da parte dell’Ordine per aprire una missione in Africa sono molto lente. Lasciando Saluzzo, scrive: “Vado a Roma, per prepararmi non so a che cosa! Il Signore lo sa, e faccia Lui, che è sempre buono” (1912). La coscienza di totale sottomissione ed abbandono in Dio, di mettere Lui al di sopra di tutto, costituisce il suo orizzonte fondamentale durante questo soggiorno a Roma. Tale spirito di abbandono in Dio è segnato in modo fortissimo da un’esperienza vissuta nel settembre del 1912, nella Basilica di San Pietro, così narrata da lui stesso: “Un giorno, prima che partissi per l’Africa, stando in ginocchio, a sinistra appena entrati nella cappella del Santissimo, schiacciato sotto il peso di gravissima afflizione, ho sentito una voce che non suonava all’orecchio, ma operava nel cuore: – Lasciati portare! Lasciati portare! Restando io un po’ oppresso ancora, e meravigliato, mi si ripeté dolcemente: – 11 Lasciati portare! Lasciati portare! Ed il cambiamento fu completo, tanto che non potei nemmeno più star lì. Mi alzai, in preda ad uno spirito nuovo che mi portava. Dove mi porterà?” (5.12.1920). La ‘gravissima afflizione’ di cui parla P. Rossetto si può individuare sia nella indeterminazione del programma missionario dell’Ordine, sia nella preoccupazione di tener nascosti al papà, gravemente ammalato, i suoi preparativi missionari. Scrive al fratello D. Giovanni: “Credo che la data di andare in missione sia alquanto lontana. Io sto bene. Del resto, come si potrebbe stare meglio di chi si abbandona, come foglia in balia del vento, alla Volontà divina, al divino Amore?” (4.12.1912). Forse, però, è necessario rifarsi anche ad un’altra grave circostanza: da Venezia, è giunta a Roma una calunnia d’ordine morale, dovuta a fraintendimenti del linguaggio usato da P. Gioachino; il “Lasciati portare” arriva come risposta all’incertezza se difendersi o no, e suona per lui come una certezza: – Non occorre che io parli! Dio mi difende! Ma, al di là di questi fatti circostanziati, l’episodio del “Lasciati portare” ritornerà sempre in tutta la sua vita come motivo dominante, caratteristico di una vocazione via via riscoperta e sempre più approfondita. Ben più tardi, infatti, ripeterà e commenterà l’espressione ai suoi Figli spirituali: “A proposito del “Lasciati portare”, ricordo che, mi pare nel settembre 1912, all’altare del Santissimo Sacramento della sua cappella in S. Pietro, a Roma, mi disse due volte distintamente: – “Lasciati portare!”, “Lasciati portare!” Mi pare molto giusto pensare che fin da allora Dio mi abbia dato una vocazione speciale: convertirmi, e quindi farmi ed essere un bambino, un figlioletto, un “figlio di Dio”. Ecco una regola ampia, larga, ed allo stesso tempo molto esigente. E mi pare che Dio mi abbia allora rivelato un amore paterno, materno, una sollecitudine, una Provvidenza tutta speciale; ma anche una vocazione da vivere ed insegnare, un ministero, un apostolato, una Missione: quella di lasciarmi portare e di insegnare a tutti a lasciarsi portare. Sì, è proprio questa la mia vocazione, è il mio programma, dato a me da Dio stesso! Se ben osservo, è stata sempre questa la volontà di Dio a mio riguardo, e spero lo sarà per sempre, se io gli sarò fedele. Che gioia per me lasciarmi portare! Oserò io scendere da quelle braccia per camminare da solo, come voglio io, e andare dove voglio io? Io però godo di poter anche dire: – E’ tutta grazia sua se mi sono lasciato portare! E’ proprio vero: so di non essere mai sceso da quelle braccia per grazia sua, e sono davvero felice” (Quaderno del Frumento, 26.1.1931). Il primato di Dio, e quindi l’abbandono in Lui, passa attraverso Cristo e la sua croce; sostanzialmente è l’accettare che ciò che conta è Dio, la sua Parola, il suo disegno, il suo progetto, rivelati e realizzati da Gesù. Sono queste le linee che attraversano l’animo di P. Gioachino nel progressivo ed altalenante definirsi dell’impegno missionario dell’Ordine. Acquista sempre più chiarezza l’insistente richiamo alla fiducia totale in Dio Padre. Questa convinzione diviene, per P. Rossetto, la via che rende il dono e l’offerta di sé stessi più assoluti, più integrali, e quindi costituisce la matrice per un vero cammino di santità. Perciò, il soggiorno a Roma è un momento forte della sua vicenda interiore, mentre, assorbito dall’opera delle missioni, cerca di prepararvisi con fervore, studiando l’inglese e facendo un po’ di pratica in ospedale. Finalmente, si verifica una prima concretizzazione: il 26 dicembre 1912 parte per Londra, per uno studio più approfondito dell’inglese, e vi rimane per circa quattro mesi. È un periodo breve, ma di intensa crescita spirituale, con un acuirsi del senso di abbandono ed umile confidenza in Dio. Proprio da Londra scrive: “Io sono felice, di quella felicità che gode ed assapora quell’anima a cui tutto e tutti dicono: – Tu non sei più di questa terra, tu sei di Dio!” (30.3.1913). Intanto l’Ordine ha accettato la missione dello Swaziland (oggi “eSwatini”, piccolo stato, totalmente inglobato nell’estremità orientale dell’Africa del Sud), con l’accordo d’inviarvi due frati ‘ad experimentum’. I due frati scelti sono P. Pellegrino Bellezze e P. Gioachino Rossetto che partono dall’Inghilterra per l’Africa il 30 aprile 1913. Lo stato d’animo di P. Rossetto traspare da una sua lettera scritta il giorno prima di partire: “È giunto il giorno mio. È il giorno del Signore: Dio ha accettato la mia povera offerta di tutto me stesso. Non dubito affatto della mia vocazione alle missioni; ma dentro a questa vocazione io ne vedo un’altra, ben più sublime: la vocazione al mio annientamento, alla mia morte. Se io la raggiungerò, sarò veramente felice, per sempre” (29.4.1913). I due missionari arrivano in Africa del Sud il 2 giugno 1913. Quasi subito devono affrontare una situazione di concreto “lasciarsi portare”: l’Ordine affida la missione dello Swaziland alla Provincia del Tirolo, che decide d’inviarvi subito due frati austriaci. Così P. Bellezze e P. Rossetto sono costretti a trasferirsi nel vicino stato del Transvaal, sempre in Africa del Sud, continuando lo studio della lingua locale ed arrangiandosi alla meglio. Con senso di umorismo, P. Rossetto scrive: “Siamo soli, e ci arrangiamo come possiamo. Io sono contento del mio sacrestano, e lui è contento del suo cuoco!” (1913). Proprio in questa sua funzione di cuoco, gli capita un piccolo incidente: feritosi alla mano destra, è ricoverato ed operato in ospedale per una pericolosa infezione. Questo lo debilita fisicamente e lo costringe all’inattività per circa un mese. L’operazione gli lascia una lunga cicatrice all’anulare destro, che egli non potrà più distendere completamente; amerà chiamare la cicatrice il “ricordo dell’Africa”, di quell’Africa che egli continuerà ad amare per tutta la vita come “sua sposa”. Anni più tardi, infatti, dopo aver incontrato Galdino, un ragazzo mulatto, figlio di soldato italiano e di mamma etiope, scrive con tenerezza: “Abbraccio con forza Galdino, il fiore dell’Africa. Non vi vedrò un fiore, mandatomi da quella mia sposa, per la quale ho pur tanto sofferto e lavorato, ed il cui ricordo porto sempre nel mio anulare? Grazie. E non vedremo in questo una conferma alla nostra vocazione di adoratrici e missionarie, di adoratori e missionari?” (4 settembre 1929). Ai primi di novembre P. Rossetto è richiamato in Italia dal suo maestro ed amico P. Lépicier, divenuto priore generale, al quale scrive: “Credo che Ella abbia ben potuto immaginare se e quanto dolorosa mi riuscì l’obbedienza che mi giunse, assieme ai dolori alla mano. Fino a pochi giorni fa non mi pareva vero. Il Signore però, a cui ho offerto subito e totalmente il mio sacrificio, mi assiste, pur lasciandomi misurare la mia debolezza. Ora sono lieto di fare quanto Egli desidera da me” (2.12.1913). Partito dall’Africa verso la metà di dicembre, giunge a Roma a metà gennaio del 1914, e si pone immediatamente a disposizione del priore generale.
Sorry, the comment form is closed at this time.